Tra pochi giorni si terranno le elezioni in Germania dopo il crollo della coalizione guidata da
Olaf Scholz, particolare attenzione all’AfD di Alice Weidel che ha polarizzato il paese e alla
CDU che ha virtualmente in mano il futuro del colosso economico europeo.
Lo scenario politico interno alla Germania
Gli occhi dell’Europa sono puntati sulla Germania, dal momento che la prossima settimana
i tedeschi saranno chiamati al voto per rinnovare il Bundestag (il parlamento tedesco). La
sfiducia al governo è arrivata ufficialmente il 16 dicembre scorso, a seguito di una crisi
iniziata il 6 novembre, quando il Cancelliere Scholz ha licenziato il ministro delle Finanze e
leader del Partito Liberale Democratico (FDP), Christian Lindner.
L’esecutivo guidato dalla coalizione “semaforo” (SPD rossi, FDP gialli e Verdi) sin da subito non ha avuto vita facile.
Ha fronteggiato la pressione di dover preservare la stabilità del paese in un periodo
caratterizzato da un susseguirsi di crisi, che solo pochi mesi dopo l’insediamento nel 2021
ha visto l’inizio del conflitto russo-ucraino e la conseguente crisi energetica, che ha
trascinato con sé l’Europa verso l’inflazione.
Le ragioni del collasso della coalizione “semaforo”
Le cause della rottura della coalizione nascono dalle tensioni sull’approvazione del
bilancio per il 2025. La politica economica promossa dai Liberali prevedeva la tutela del
freno al debito e il taglio delle spese pubbliche, con l’obiettivo di non sforare i limiti di bilancio
stabiliti. Questo principio che prende il nome di Schuldenbremse è parte della costituzione
tedesca dal 2009, e prevede che il governo federale non possa alzare il deficit strutturale
oltre lo 0,35% del PIL.
Tensioni su questo tema erano già note, riguardo a investimenti proposti da SPD e Verdi per
la difesa e per il clima, ma sono affiorati formalmente solo più avanti, nello specifico ad
ottobre, quando Scholz e la ministra degli Esteri Annalena Baerbock (Verdi) hanno proposto
un pacchetto da 3 miliardi di euro di aiuti militari per l’Ucraina. Il FDP ha bloccato la misura,
rifiutando nuovi debiti e accusando gli alleati di irresponsabilità politica. Seguì il
licenziamento di Christian Lindner da parte del capo di governo. Questo gesto, interpretato
dal FDP come un tradimento, ha portato al crollo della coalizione facendo perdere a Scholz
la maggioranza.
Il processo elettorale per le elezioni in Germania
Le prossime elezioni federali si terranno il 23 febbraio 2025. Il sistema elettorale tedesco è
misto, e combina elementi proporzionali e maggioritari. Gli elettori dispongono di due voti
distinti: un primo voto (Erststimme) che permette di eleggere un candidato nel proprio
collegio uninominale, il candidato che ottiene la maggioranza relativa dei voti nel collegio
viene eletto direttamente al Bundestag.
Il secondo voto (Zweitstimme), invece, sceglierà una lista di partito a livello regionale
(Länder) e determinerà la distribuzione proporzionale dei seggi nel Bundestag tra i vari
partiti.
Una peculiarità del sistema elettorale tedesco è il numero totale dei seggi che può variare a
causa dei meccanismi di compensazione previsti per garantire la proporzionalità. Ma da
questa legislatura il Bundestag conterà “solo” 630 seggi, a seguito della riforma elettorale del
2023, che ne ha bloccato il numero.
La soglia di sbarramento per ottenere una rappresentanza al Bundestag chiede almeno 5%
dei voti a livello nazionale o la vittoria in almeno tre seggi nei collegi uninominali.
Forze politiche in gioco
I principali partiti che concorrono alle elezioni in Germania sono sette. Oltre i
Socialdemocratici (SPD), i Verdi ed i Liberali (FDP) che già erano al governo, alle elezioni
parteciperanno la Linke, formazione di estrema sinistra e la sua ala scissionista guidata da
Sahra Wagenknecht (BSW), la CDU leader nel centrodestra (il partito di Angela Merkel per
intenderci) e la tanto discussa Alternative für Deutschland (AfD), rappresentante
dell’attuale estrema destra tedesca.
I candidati per la cancelleria sono: per SPD l’uscente Scholz, per i Verdi Annalena Bearbock
o Robert Habeck, per i Liberali Christian Linder (sopracitato autore della crisi di governo),
per Linke Jan van Aken o Heidi Reichinnek, per BSW l’omonima Sahra Wagenknecht, i nomi
più attesi dai sondaggi sono Friedrich Merz per la CDU ed Alice Weidel per AfD.
La crisi tedesca
Dal 2019 in Germania vi è una crescente contrazione della produzione manifatturiera
(settore fondamentale che contribuisce al 21% del PIL), la cui causa principale è la crisi
energetica:, il paese, come tutta l’Unione, dipende ancora troppo dagli idrocarburi e la crisi
russo-ucraina ha colpito duramente. Gli accordi siglati con Mosca negli anni sono stati molto
convenienti, tramite contratti pluriennali con la compagnia statale Gazprom e l’ampliamento
delle infrastrutture come il Nord Stream 2, gasdotto che avrebbe duplicato la portata di gas
introdotto in Europa a costi ridotti, bloccato a febbraio 2022 dopo l’invasione russa
dell’Ucraina.
La dipendenza energetica dalla Russia si è rivelata un’arma a doppio taglio che ha portato i
paesi europei, ed in particolare la Germania, a dover correre ai ripari cercando nuovi
partner per le importazioni energetiche. L’aumento di domanda verso altri paesi, insieme alla
riduzione forzata degli idrocarburi russi, ha portato a picchi del prezzo dell’energia durante il
2022, influenzando indirettamente il mercato e le aziende europee che hanno visto lievitare i
costi.
Un’altra ragione del calo della produzione nel paese è il ristretto uso delle finanze
pubbliche, in virtù del Schuldenbremse.
Politiche fiscali che hanno ridotto gli investimenti pubblici ed un welfare accomodante hanno
generato una carenza di manodopera, ciò ha disincentivato investimenti esteri e ha portato
le aziende tedesche a delocalizzare le attività in paesi con politiche più favorevoli per
l’impresa, come la Polonia.
A differenza di altri paesi europei come Francia e Italia, la Germania avrebbe ampie
possibilità di portare avanti manovre fiscali espansionistiche, per incentivare la
produzione e la crescita del paese. Tuttavia, sembra che la stabilità fiscale nella politica
economica tedesca sia diventata un obiettivo ideologico da preservare ad ogni costo, in
memoria della dissolutezza nella gestione delle finanze che portò all’iperinflazione durante la
Repubblica di Weimar.
Le crescenti divisioni sociali e territoriali
La Germania, in quanto repubblica federale, è divisa in sedici Länder, rappresentati nel
Bundesrat (Consiglio Federale), la seconda camera del Parlamento tedesco, composto da
membri dei governi regionali. Ogni Land dispone di un numero di seggi che può variare da
tre a sei, in base alla popolazione. Questo organo lavora insieme al Bundestag al processo
legislativo nazionale. I Länder detengono oltre al ruolo legislativo competenze esclusive in
vari settori, tra cui l’istruzione, la polizia e l’amministrazione locale.
Il terreno fertile per le forze estremiste
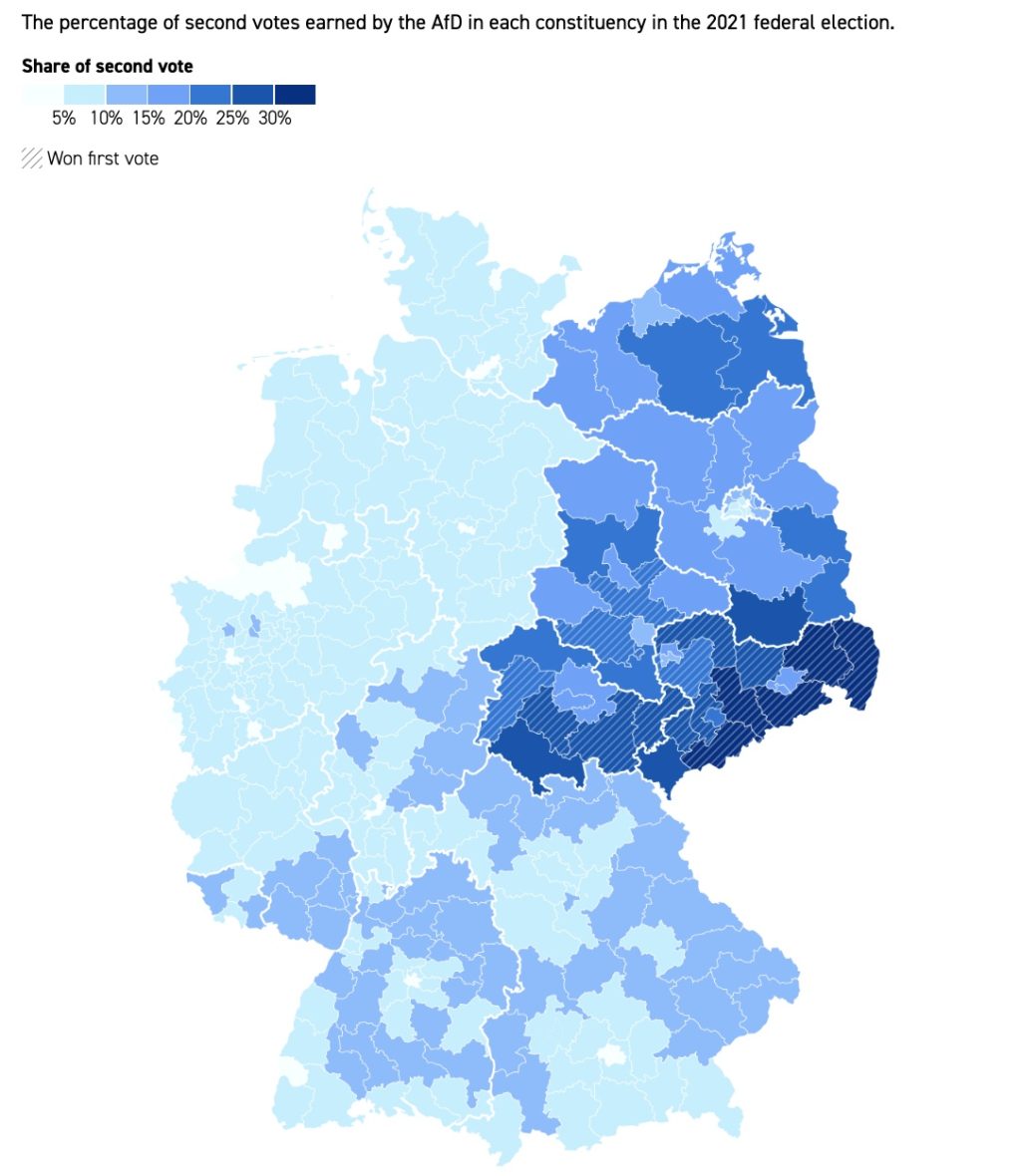
A quasi 36 anni dalla caduta del Muro di Berlino, sembra esistere ancora una barriera
socioeconomica a dividere le due Germanie, da cui si alimenta il risentimento politico
verso l’elite, da parte dei Länder dell’est, che si percepiscono abbandonati e
deindustrializzati. Questi sono stati i più colpiti dalla fine dei rapporti energetici con la Russia
e dalla nuova austerità, e non a caso vedono in AfD una speranza per staccarsi il più
possibile dalla Russia e alimentano la sfiducia per le forze politiche tradizionali (CDU e SPD)
che negli ultimi anni vi hanno collaborato come principale alleato in Europa.
Il “muro di fuoco” in mano a Merz
A poche settimane dalle elezioni in Germania, il leader della CDU Friedrich Merz
sembra favorito a diventare il nuovo cancelliere, e in più occasioni ha dichiarato di voler
mantenere una linea di distacco nei confronti dell’AfD, negando ogni possibile
coinvolgimento nel nuovo governo del partito di estrema destra tedesco. Questo rifiuto si
basa sulla natura populista, euroscettica e anti-immigrazione dell’AfD, che Merz e altri leader
della CDU considerano incompatibile con i valori del partito.
Tuttavia, nonostante questa sia la posizione ufficiale, ci sono stati segnali contrastanti: ad esempio episodi di collaborazione
regionale in alcuni Länder dell’est, si sono verificati casi di coalizioni tra CDU e AfD nelle
amministrazioni locali, meno di un mese fa, veniva invece sostenuto da AfD un disegno di
legge controverso sulla politica migratoria proposta da Merz e bocciato dal Bundestag,
alimentando il dibattito sulla tenuta del “muro”.
L’Alternative für Deutschland di Alice Weidel
L’AfD, considerato il movimento sovranista più a destra dal secondo dopoguerra, si trova al
20% negli ultimi sondaggi, e potrebbe confermarsi secondo partito alle elezioni in
Germania.
Il partito si presenta come la novità che vuole sovvertire l’élite europeista alla guida politica
tedesca, e gioca sul risentimento della parte del paese più povera, proponendo una visione
fortemente euroscettica, anti-migratoria, negazionista del cambiamento climatico e
ampiamente conservatrice sui diritti civili. In politica estera sostiene Nato e USA, ma si
schiera contro le sanzioni alla Russia, proponendo rapporti più distesi con Mosca.
Un forte sostegno ad AfD è arrivato dalla Casa Bianca.
In occasione della Conferenza sulla Sicurezza di Monaco, il vicepresidente Vance ha incontrato Alice Weidel, rinforzando il
precedente endorsement di Elon Musk, e segnando una rottura con la tradizionale politica
estera americana. Durante il discorso, Vance ha aperto alle forze estremiste in Europa,
criticando i paesi europei per l’esclusione dei partiti di estrema destra dai governi, e
suggerendo che tale pratica limiti la democrazia.
Eventi e dichiarazioni dei suoi militanti, considerati neonazisti, hanno portato ad un
isolazionismo politico del partito, e ad innumerevoli manifestazioni per chiederne lo
scioglimento, da quella parte della popolazione che vuole evitare fermamente che l’estrema
destra torni alla guida, in una Germania mai stata così divisa nella sua storia federale.
*crediti grafico: Bundeswahlleiterin



![Unione Fiscale e momento hamiltoniano [credit: Unsplash]](https://www.orizzontipolitici.it/wp-content/uploads/2020/10/guillaume-perigois-0NRkVddA2fw-unsplash-scaled.jpg)

