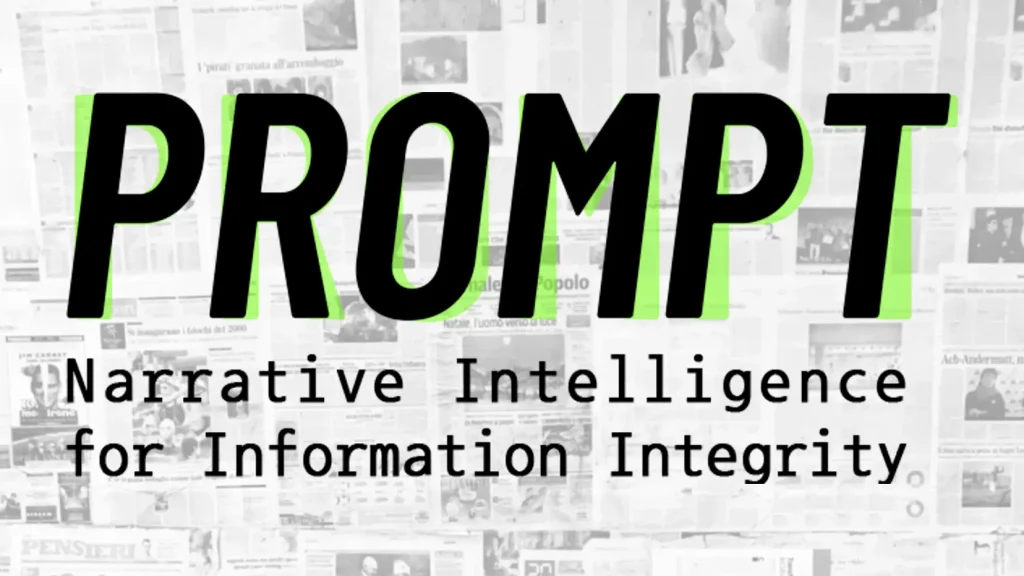Nel precedente articolo abbiamo introdotto il progetto pilota co-finanziato dall’UE, PROMPT. In questa analisi, invece, vedremo insieme le metodologie studiate dai suoi esperti, e sfruttate nei casi di studio sulla guerra in Ucraina e sulle passate elezioni in Romania.
Le metodologie
I tecnici di PROMPT per intercettare le narrazioni manipolative hanno sviluppato una matrice semantico-assiologica. In seguito hanno implementato modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) e strumenti in grado di mappare le narrazioni, le pratiche di diffusione specifiche, e i tipi di interazione. Sfruttano anche strumenti come flussi (pipelines), identificazione narrativa e modellazione multistrato (multilayer modelling) nell’analisi di rete (Network analysis).
Se quanto detto finora non suona propriamente familiare, questo articolo servirà proprio per analizzare e spiegare come queste tecniche sono state utilizzate nel progetto PROMPT. Per approfondirne gli aspetti tecnici, il rimando è alla sezione pubblicazioni del progetto.
Analisi automatizzata dei contenuti tramite matrice semantico-assiologica
PROMPT sfrutta modelli di AI (Intelligenza Artificiale), i quali permettono un’analisi automatizzata dei contenuti online. Tali modelli, per riuscire ad individuare gli elementi di disinformazione, vengono integrati con strumenti analitici della linguistica, come la matrice semantico-assiologica. Questa è una struttura analitica che combina significati linguistici e valori culturali per identificare come un contenuto costruisce narrazioni manipolative, persuasive o polarizzanti. Non è dunque una “matrice” informatica, ma una griglia che combina significati (semantica) e valori (assiologia) per comprendere come un messaggio costruisce la sua forza persuasiva.
Analizzare il fenomeno delle narrazioni manipolative richiede strumenti che vadano oltre la semplice verifica dei fatti. Gli esperti di PROMPT hanno bisogno di decifrare non solo cosa viene detto di falso, ma soprattutto come e perché quel messaggio riesce a penetrare l’immaginario collettivo. È in questo contesto che emerge l’importanza della matrice semantico-assiologica. Questo strumento analitico funge da vero e proprio “scanner” retorico, permettendo ai ricercatori di scomporre la narrazione in elementi misurabili.
Ma come lavora esattamente? Sono quattro le funzioni primarie, chiaramente interconnesse tra loro:
- Mappatura del linguaggio manipolativo: classifica sistematicamente il linguaggio allarmistico, metafore emotive e meccanismi di polarizzazione (ad esempio, “noi contro loro”) impiegati per aggirare il pensiero critico e innescare reazioni istintive.
- Riconoscimento delle leve valoriali: permette di riconoscere i valori profondi – come la sicurezza, l’identità nazionale o le tradizioni – manipolati in modo mirato.
- Analisi transnazionale delle narrazioni: fornisce una base strutturata per comparare come le stesse narrative si adattano in contesti culturali e linguistici diversi.
- Fondamento per l’AI: come detto in apertura, la sua struttura logica e categorizzata è essenziale per addestrare gli LLM. Trasformando la retorica in pattern riconoscibili, la matrice consente all’analisi automatica di identificare le strategie di manipolazione su vasta scala, velocizzando l’individuazione di nuove campagne di influenza.
I workshop con il consorzio
Lo sviluppo e la validazione della matrice analitica rappresentano uno sforzo congiunto di tutti i partner di PROMPT. Attraverso una serie di workshop tecnici, i collaboratori del progetto hanno proposto e analizzato esempi concreti di disinformazione, fornendo contributi che hanno guidato le revisioni finali della matrice.
Un concetto chiave emerso da questo processo collaborativo è stata l’importanza di bilanciare i rigidi standard giornalistici, come la fattualità, le tipologie di disinformazione e la verificabilità, con dimensioni meno affrontate nell’analisi tradizionale. Esempi rilevanti sono gli attributi assiologici (i valori “nascosti”) e i dispositivi retorici utilizzati per la persuasione. Questa tipologia di analisi prende le mosse da una particolare raccolta di codici studiata dagli esperti di PROMPT, vale a dire il Codebook.
Il linguaggio della disinformazione
Il Codebook è un sistema di codifica che integra caratteristiche linguistiche, strategie retoriche e tecniche di manipolazione informativa. Strutturato in un catalogo di 30 gruppi e 240 codici individuali, esso è lo strumento concettuale che abilita de facto l’analisi automatizzata. Questo perché la sua raccolta di codici facilita l’identificazione di contenuti progettati per incitare divisione o manipolare l’opinione pubblica. Attraverso questo sistema, nei campioni analizzati è stato individuato l’uso sistematico di un vocabolario aggressivo o allarmista. Termini come “invasore”, “minaccia”, “catastrofico” ed “epidemia” non sono casuali, bensì vengono impiegati strategicamente per infiammare il dibattito e distorcere la percezione degli eventi.
Superata la fase iniziale di test, la metodologia di analisi ha compiuto un salto di qualità. Il Codebook è stato infatti ampliato per integrare un’analisi più sofisticata che analizza come il linguaggio impiegato nei post sui social si allinei con le diverse ideologie politiche. L’obiettivo è quello di mappare l’ecosistema narrativo completo della propaganda moderna, che dai movimenti illiberali in occidente alle reti tra Cina e Russia converge nel tentativo di indebolire la fiducia nella democrazia.
Le categorie del Codebook
Supportate dall’AI e dai LLM, tutte le categorie del framework (il sistema metodologico) PROMPT convergono nella creazione di un toolkit (strumentario) completo per l’analisi della disinformazione. Questo sistema avanzato è progettato specificamente per rilevare le sottili sfumature linguistiche nel discorso pubblico: quelle che possono facilmente sfuggire all’osservazione umana, ma che sono decisive nel modificare il messaggio trasmesso. Questi cambiamenti di significato giocano, infatti, un ruolo cruciale nel determinare come la disinformazione viene percepita e recepita con successo sulle piattaforme digitali.
Per garantirne una mappatura completa, gli esperti hanno strutturato il Codebook in cinque sezioni distinte, ognuna progettata per risaltare aspetti fondamentali dell’ecosistema della disinformazione:
- Cosa? (Analisi del contenuto visibile nel post sui social media)
- Dove? (Origine e area geografica coperta dal post)
- Chi? (Autore, target e audience prevista)
- Come? (Modalità di diffusione della disinformazione)
- Perché? (Motivazioni che guidano la distribuzione del post)
La Network Analysis
L’analisi di rete (Network Analysis) costituisce il segmento conclusivo e cruciale del lavoro di PROMPT, incaricato di identificare come specifici cornici narrative e claim di disinformazione si propagano sui social media. Questo metodo di analisi dinamica si articola sostanzialmente in tre fasi:
- Metodologia di Identificazione Narrativa. Si realizza utilizzando gli LLM per classificare i post in gruppi narrativi definiti per topic e posizione; si va oltre l’identificazione di contenuti identici, per rilevare il coordinamento attorno a delle narrazioni condivise.
- Flusso di Classificazione Controllata Supportata dagli LLM. Questa fase operativa impiega il Codebook definito dagli esperti. Attraverso un processo di apprendimento supervisionato, dei modelli di trasformazione multilingue vengono addestrati su campioni annotati manualmente dagli esperti per riconoscere automaticamente le narrazioni. Attualmente, al fine di preservare l’interpretabilità del modello e per prevernirne una deriva autonoma, il sistema integra una validazione con intervento umano (human in the loop) per correggere eventuali errori su contenuti ambigui, garantendo un’accuratezza del 75% circa e producendo dati pronti per la successiva analisi di rete.
- Analisi delle Reti di Propagazione Narrativa. Dopo la classificazione, si costruiscono grafici di co-diffusione e reti di interazione (usando metadati come retweet, citazioni e quote tweet). Questo approccio rivela la struttura della diffusione, consentendo di identificare gli attori influenti, i cluster (gruppi) di amplificazione coordinata e gli utenti “ponte” che connettono comunità altrimenti separate. In sintesi, l’analisi di rete traduce i dati testuali classificati in mappe dinamiche di influenza e diffusione del contenuto.

Un nuovo paradigma per la Difesa dell’informazione
In definitiva, i tecnici del progetto PROMPT con la metodologia sviluppata possono generare una svolta nella lotta alla disinformazione. In contrasto con il tradizionale e laborioso fact-checking manuale, questo approccio ibrido fonde il rigore qualitativo della matrice semantico-assiologica con la potenza di calcolo dell’Intelligenza Artificiale e la precisione della Network Analysis.
Non si tratta più soltanto di distinguere il vero dal falso, ma di comprendere l’ecosistema stesso della manipolazione: come le narrazioni vengono costruite per richiamare i valori di una comunità, chi le propaga strategicamente e attraverso quali canali (o comunità) esse infiammano il dibattito pubblico.
Offrendo un toolkit che è al contempo teoricamente solido e tecnologicamente scalabile, PROMPT fornisce a ricercatori e giornalisti le armi necessarie per non essere semplici spettatori, ma difensori attivi dell’integrità informativa.
*Immagine di copertina: PROMPT project logo via The European Narrative Observatory/PROMPT